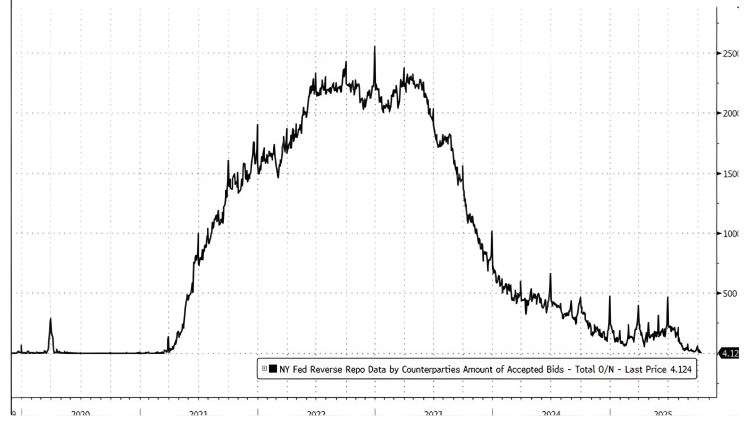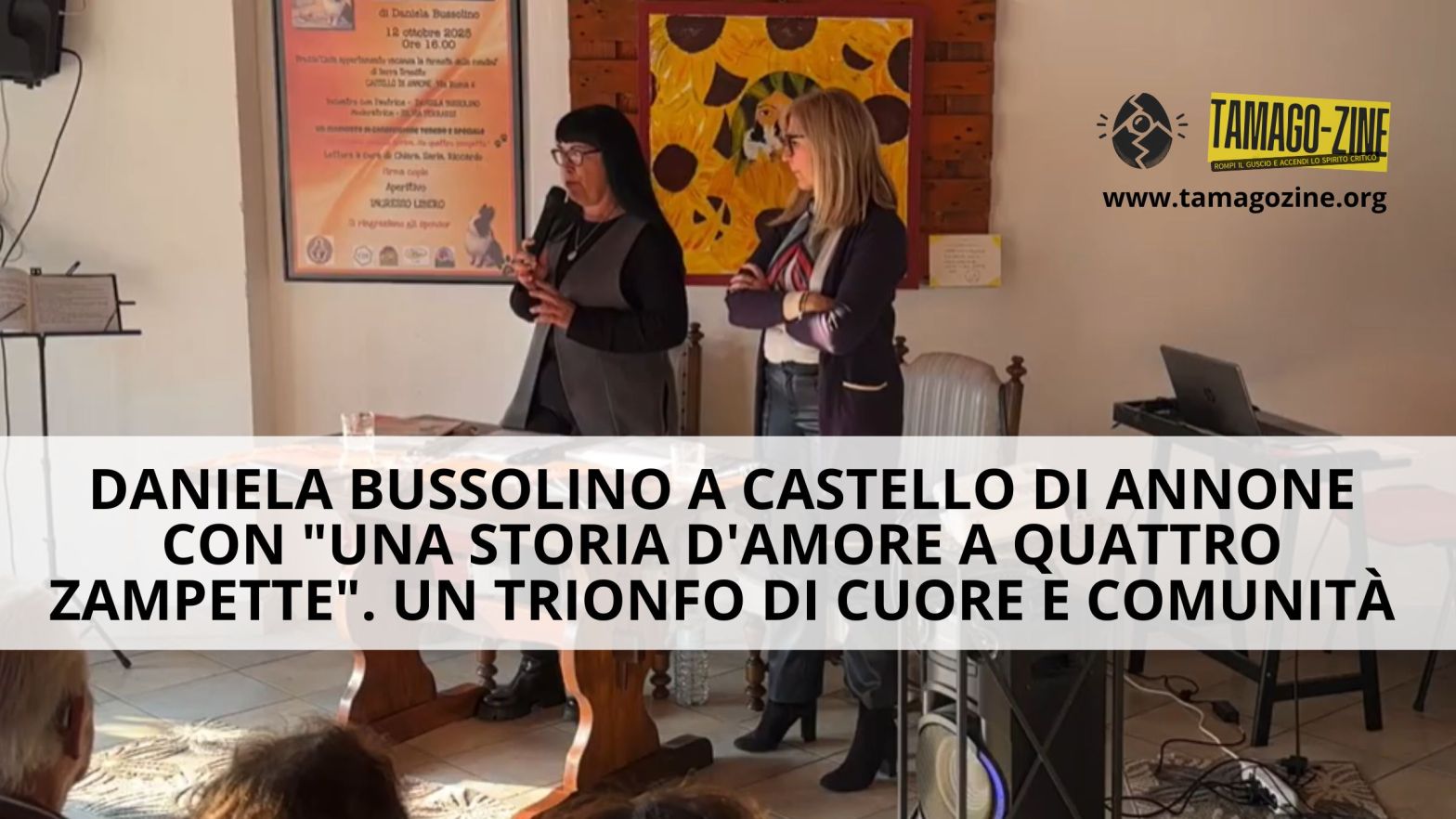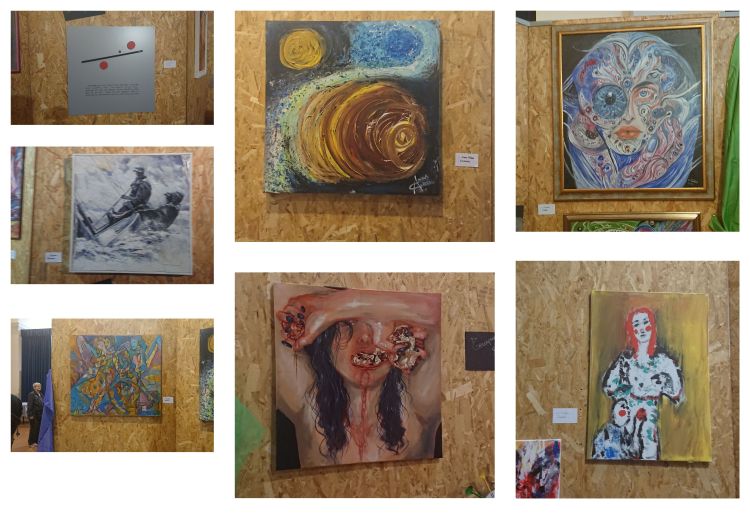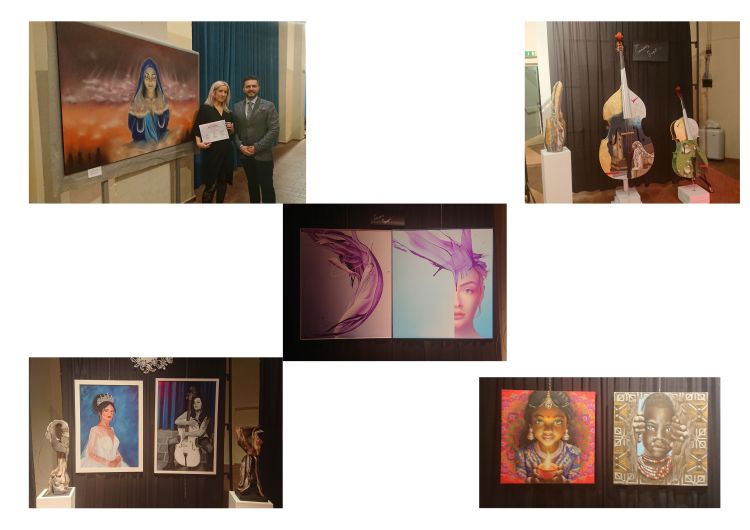IL VERTICE TRUMP-PUTIN TRASFORMA L’UNGHERIA IN UN PALCOSCENICO CHE POTREBBE RIDISEGNARE I CONFINI DEL POTERE E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
C’è un fantasma che si aggira per l’Europa.
Lo so, fa un po’ cliché da melodramma, ma noi siamo spettatori di una commedia in più atti che sta ridisegnando i rapporti mondiali.
E lo spettro che si aggira per l’Europa non è ideologico, ma potrebbe essere a breve il profilo luccicante di un aereo di stato russo che cerca un varco nei cieli ostili del continente.
La sua destinazione è l’Ungheria. A bordo, Vladimir Putin. Un uomo che la Corte Penale Internazionale vuole in una cella all’Aia per crimini di guerra.
Ma ad attenderlo non ci sono manette, bensì un tappeto rosso e la stretta di mano di Donald Trump, leader di quello che noi occidentali definiamo mondo libero.
E per chi già avverte la bile salire in gola, invito a ricordare che anche Netanyahu è volato più volte a destra e a manca senza che nessuno abbia applicato il mandato d’arresto internazionale che pende sulla sua testa per crimini di guerra e contro l’umanità.
Va ricordato anche che l’Italia ha permesso il rilascio di Elmasry, contrariamente a quanto stabilito dalla CPI. Perciò, si troverà un modo anche per Putin.
Ok, tornando all’incontro Putin-Trump, non fatevi ingannare.
Non sarà un vertice di pace, ma un test di rottura. Un esperimento condotto in territorio della NATO e di un’Unione Europea sempre più fragili, orchestrato da un uomo che ha trasformato la sua nazione in un laboratorio di sovranismo: Viktor Orbán.
L’incontro che si consumerà sulle rive del Danubio non è un dialogo diplomatico, dunque, ma una performance, un atto di comunicazione politica brutale che mira a scardinare l’ordine mondiale post-Guerra Fredda. Una sorta di secondo atto dopo il primo andato in scena in Alaska.
Sul palco ci saranno tre uomini, ma ognuno rappresenta un archetipo della nostra era incerta e caotica.
Trump, l’imprenditore cinico che crede che la lealtà alle alleanze sia un costo negoziabile. Putin, il reietto che cerca disperatamente una via d’uscita per legittimare la sua guerra e piegare i suoi nemici. Infine Orbán, il regista, il ponte astuto tra due mondi che usa questa crisi per consacrare la sua visione di un’Europa alternativa a quella belligerante di von der Leyen, Merz e Macron.
LA “SOVRANITÀ” UNGHERESE
«Faremo in modo che entri in Ungheria… e poi che torni a casa». Le parole del Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto sono un dichiarazione di indipendenza non solo dalle politiche belligeranti di Bruxelles, ma dall’intero sistema di valori e obblighi legali su cui si fonda l’Occidente.
Tuttavia, se lo fa l’America con Netanyahu, non si capisce perché l’Ungheria non dovrebbe farlo con Trump e Putin.
Per capire la portata di questo gesto, bisogna guardare oltre la retorica. Bisogna guardare agli atti.
L’atto più eloquente è la decisione di Budapest di avviare il processo di recesso dalla Corte Penale Internazionale. Non certo una coincidenza, bensì la preparazione del terreno. Un porto franco non solo per Putin, ma per chiunque, come Netanyahu, si trovi nel mirino di quella giustizia internazionale che Orbán percepisce come un’arma delle élite globaliste contro le nazioni sovrane.
E visto il doppiopesismo dell’Occidente nel trattare Putine e Netanyahu, come dargli torto?
Un allineamento alla stessa America, definita la più grande democrazia del mondo, che, ricordiamolo, non riconosce la Corte Penale Internazionale, come, tra gli altri, Israele, Cina, Russia.
Quando Orbán definisce l’Ungheria “l’isola della PACE”, compie un’operazione sociologica magistrale, costruendo una narrazione potente per il suo popolo e per i suoi alleati ideologici: noi, i pacificatori pragmatici, insieme a russi e americani, contro un’Europa “pro-guerra” intrappolata in una crociata morale contro la Russia.
In questa narrazione, offrire un palcoscenico a un ricercato internazionale non è un tradimento, ma l’emulazione di quanto fatto da Trump con Netanyahu. È un atto di coraggio. E anche un atto di elevata visione politica in un’Europa di nani politici.
IL FANTASMA DELL’AIA E LA SCACCHIERA DEI CIELI
Ma come arriva un fantasma a destinazione?
Putin non è colpito da un divieto di viaggio personale dell’UE, ma il suo aereo, come ogni velivolo russo, non può sorvolare lo spazio aereo dell’Unione.
Ogni chilometro del suo percorso, pertanto, sarà una negoziazione, un test di lealtà, una potenziale umiliazione.
La via ostile è una linea retta che attraversa la Polonia e la Slovacchia. Sarebbe la rotta più breve, ma anche la più rischiosa. Costringerebbe il Cremlino a chiedere un’autorizzazione formale a Varsavia, una nazione che vede ogni drone nel cielo come una minaccia russa e vorrebbe un attacco “profondo” della NATO alla Russia.
Sarebbe una resa simbolica, un’ammissione di dipendenza dalla Polonia che Putin non concederà mai.
La via tortuosa è un percorso più lungo, più a sud. Un arco che evita i nemici più accaniti, passando forse dal Mar Nero, sopra una Turchia funambola e neutrale, per poi cercare un varco nei Balcani.
Questa rotta, molto probabile, è la dimostrazione vivente che Putin ha ancora amici, o almeno partner pragmatici, anche in Occidente, disposti a chiudere un occhio.
E ogni autorizzazione di sorvolo concessa sarà una crepa nel muro della solidarietà occidentale.
OLTRE LA PACE, IL POTERE
Non illudiamoci che l’obiettivo sia la pace per l’Ucraina. L’obiettivo è il potere. Per tutti e tre.
Per Vladimir Putin, questo vertice è ossigeno. È la possibilità di rompere l’isolamento asfissiante. Sedersi al tavolo con Trump, dopo le sparate del mainstream sul presidente americano deluso da Putin, è un ritorno sulla scena mondiale da trionfatore, proprio come in Alaska, una foto che vale più di mille sanzioni.
L’obiettivo non è un accordo giusto, ma un accordo che congeli le sue conquiste, che crei una “Corea” in terra ucraina e che gli permetta di dichiarare una vittoria strategica in patria. Una pace come la resa di Hamas per cui quasi tutti festeggiano perché si smette di uccidere.
E se smettere di uccidere non è giusto…
Per Donald Trump, la logica è ancora più spietata.
Il ritorno sull’investimento politico di questo vertice sarebbe enorme. Potrebbe presentarsi agli elettori americani come l’unico leader capace di “risolvere” le guerre che i burocrati di Washington hanno solo saputo finanziare. Dopo Gaza, anche Kiev.
La fine del conflitto, a qualsiasi costo per l’Ucraina, diventerebbe il suo più grande trofeo elettorale, la prova definitiva della sua abilità e della sua superiorità sia sui democratici sia sui leader europei.
L’Ucraina, in questo calcolo, non è una nazione da salvare, ma un asset da negoziare.
LA VOCE DI KIEV, IL SILENZIO DI BRUXELLES
Mentre a Budapest si preparano i tavoli dei negoziati, c’è un’altra scena che si svolge a migliaia di chilometri di distanza.
Il Presidente Volodymyr Zelenskyy non è in un palazzo dorato, ma impegnato in un pellegrinaggio per la sopravvivenza a Washington, a mendicare missili Tomahawk per impedire che il suo Paese venga cancellato dalla mappa.
Eppure, c’era chi ci raccontava di controffensive risolutive, dei missili Patriot che avrebbero cambiato il corso della guerra, dei caccia F16 che avrebbero messo in scacco la Russia – a proposito, qualcuno ne ha notizia?
Persino le nostre sanzioni “dirompenti” avrebbero annientato Mosca in pochi mesi, nel 2022.
Ora, invece, l’Ucraina è messa molto peggio di tre anni fa e chiede ancora armi risolutive, in questo caso missili potenti, sì, ma che darebbero a Mosca il pretesto per usare armi ben più pesanti in risposta.
Ma la realtà di Zelensky non è fatta di calcoli geopolitici, ma di trincee fangose, di sirene antiaeree, di vite spezzate. Una realtà che ha disegnando dopo che Boris Johnson lo ha convinto a rigettare gli accordi in Turchia del 2022.
Zelensky è appeso a un filo e attaccato alla poltrona perché sa che, finita la guerra, sarà finita anche la sua carriera politica. E, forse, non solo quella.
Si parla di pace sull’Ucraina, ma senza l’Ucraina. È un’eco spettrale di Yalta e di Monaco, ma è la dimostrazione che la guerra è combattuta in Ucraina, ma tra USA e Russia, come abbiamo sempre ricordato fin dal 2022.
E l’Europa?
L’Unione Europea accoglie la notizia con “cauta positività”.
È un balbettio diplomatico. È il suono dell’impotenza. Incapace di imporre una linea a un membro ribelle come l’Ungheria, per non aizzare i popoli europei che in ogni recente elezioni hanno votato contro la guerra, l’Europa è costretta ad assistere a un vertice che demolisce la sua stessa politica di isolamento di Mosca.
Un vertice che dimostra quanto l’Europa sia un’accozzaglia di paesi retti da nani di geopolitica in cui riesce perfino a spiccare – e a fare molto meglio di loro – uno come Orbán.
La cautela di questa Europa non è saggezza, come qualcuno potrebbe pensare, ma è la dimostrazione lampante della paralisi di chi si rende conto che le fondamenta della propria casa stanno cedendo, ma non ha alcuna competenza per poter fare qualcosa.
L’ECO DI BUDAPEST COME YALTA O MONACO?
Indipendentemente da ciò che verrà firmato, o non firmato a Budapest, qualcosa si è già rotto. L’azzardo di Orbán ha dimostrato che un singolo leader, agendo con spregiudicata determinazione, con coraggio e con una visione non comune nell’Europa odierna, può sfidare e incrinare l’intero edificio dell’ordine bellicista europeo.
Stiamo guardando in diretta la balcanizzazione dell’Occidente, con leader sovrani che tracciano le proprie rotte, ignorando il diritto internazionale e le alleanze storiche. Lo abbiamo visto in America con Netanyahu e lo vedremo anche in Europa con Putin.
Forse, anche i più sognatori si renderanno conto che al mondo comandano i più forti, come è sempre stato, e che le paci giuste non sono mai esistite, ma esistono sempre e solo negoziazioni tra presidenti alla guida degli eserciti più potenti. E basta studiare la storia per comprenderlo.
Mentre il mondo trattiene il fiato, sperando in un segnale di pace, – fatta eccezione per i leader europei più belligeranti e per chi ha interessi nelle fabbriche di armi – ciò che potrebbe emergere dalle nebbie del Danubio non è la pace, ma il profilo di un nuovo equilibrio di potere.
E la pace, se mai arriverà, sarà la resa non solo di territori, ma di principi. Quelli su cui, per settant’anni, abbiamo provato a costruire un mondo migliore.
Ma sono gli stessi principi morti con la pace di Gaza per cui tanti applaudono e festeggiano. Perché negli ultimi settant’anni abbiamo vissuto l’idea di una realtà parallela che è solo un sogno.
Tuttavia salvare vite, con o senza paci giuste impossibili, è la priorità, senza se e senza ma.

Dott. Pasquale Di Matteo
Giornalista freelance, esperto di Politiche Internazionali ed Economia, Comunicazione e Critica d’arte. Laureato in Scienze della Comunicazione, con un Master in Politiche internazionali ed Economia, rappresenta in Italia la società culturale giapponese Reijinsha.Co.