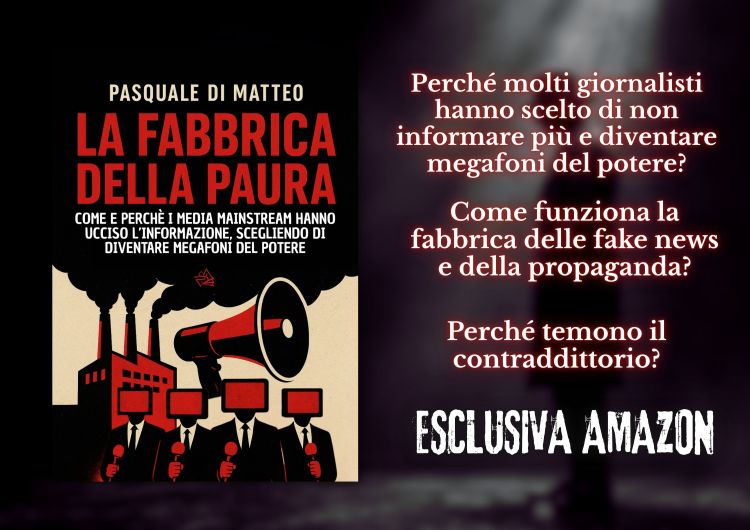di Redazione TZ
Esiste una forma di eroismo silenzioso nel gesto di rimanere per ore, immobili, davanti a un cavalletto, a meditare, in attesa di quell’illuminazione che porti a realizzare l’immagine mentale sulla tela, per meglio veicolare ciò che si vuole comunicare.
Franco Bulfarini è un artista che ha saputo trasmutare la staticità dello studio in un dinamismo metafisico travolgente, facendo della pittura qualcosa di più di un semplice atto di isolamento, ma un viaggio verso il centro del proprio essere.
Per usare le sue parole: «Il massimo nella vita è poter dare qualcosa di sé alla società; io cerco di fare questo attraverso la dimensione dell’arte. Potrei fare altro, ma sento che questo è quello che mi riempie il cuore. L’arte porta oltre la materia, si avvale della materia per condurre nel mondo dello spirito. E questo è un viaggio meraviglioso che merita il sacrificio e la fatica di una vita statica davanti a un cavalletto, ma al contempo enormemente dinamica sul piano immateriale.»
Dal 24 gennaio all’11 febbraio 2026, la Galleria d’Arte “Jacopo Cavedoni” di Sassuolo ospiterà la mostra “Figurazione Avveniristica e Città Impossibili”, una personale che promette di scardinare le nostre certezze percettive.

Quella di Franco Bulfarini non è una comune mostra, con opere d’arte appese alle pareti, ma un invito a varcare la soglia di un multiverso dove i lavori dell’artista non sono soltanto colori e tratti, ma vibrazioni dell’anima e filosofia esistenziale donati al mondo.
«L’arte è una forma di comunicazione non verbale efficacissima» ci dice l’artista, «e possiede la capacità di far emozionare il fruitore coinvolgendolo all’interno del progetto artistico. Una personale non è solo “una o due opere da mettere in visione”, ma è un progetto, un percorso che l’artista mette in visione, e il fine è di emozionare, o di far riflettere, di aprire un’interazione grazie alla pittura.»
LA TERZA VIA: OLTRE L’ASTRAZIONE E LA FIGURAZIONE
La ricerca di Bulfarini nasce da una necessità interiore profonda, un percorso iniziato tra i fogli di un tinello e approdato a una sintesi formale di rara potenza.
Formatosi attraverso lo studio delle avanguardie storiche, con lo sguardo rivolto alla liricità di Kandinsky e alla profondità di Klee, l’artista ha sentito il bisogno di tracciare una “terza via”, una sintassi nuova, una grammatica del colore personale.
Non si è accontentato dell’astrazione pura, che spesso sacrifica la profondità, né della figurazione tradizionale, perciò ha scelto di unire questi mondi, introducendo la prospettiva nell’astrazione, dando vita al suo linguaggio originale.
Il risultato è un unicum stilistico dove lo spazio, inteso sia come micro che come macrocosmo, diventa il vero protagonista. In ogni opera, Bulfarini cerca di ricomporre i tasselli del proprio animo, dando un senso cromatico a un’esistenza che, senza l’arte, sarebbe priva di luce.
DUE CICLI, UN SOLO CUORE: FIGURAZIONE AVVENIRISTICA E CITTÀ IMPOSSIBILI
L’esposizione si articola lungo due direttrici fondamentali che rappresentano le due anime dell’artista.
Da un lato, troviamo il ciclo della “Figurazione Avveniristica”, dove Bulfarini esplora l’infinito possibilistico della natura attraverso la rotondità, l’ellissi, e quel dinamismo curvilineo che è il codice genetico che regola ogni cosa, del mondo e dell’universo.
Dall’altro lato, le “Città Impossibili” si presentano come labirinti geometrici e mentali, mondi che nascono dall’universo interiore di Bulfarini, ma che, in fondo, sono soltanto percezioni che l’artista trasforma in opere d’arte come mappe segrete riportate alla luce e donate al mondo.
In questi luoghi, l’artista riflette sulle opacità dell’umanità e sulle criticità del nostro tempo. Sono architetture del pensiero che indagano le speranze e le incongruenze dell’uomo contemporaneo, trasformando la tela in un campo di indagine sociologica e filosofica.
Opere in cui ciascun osservatore è costretto a impegnare la propria mente, a meditare, a lasciarsi trasportare dalle proprie emozioni per decifrare il codice segreto del linguaggio dell’artista.








L’ARTISTA NELL’ERA DEL MULTIVERSO E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
«Oggi si parla e si vive con la protesi dell’AI, con la robotica che ci vive accanto, con i viaggi spaziali alle porte, e, guardando in alto, non vediamo solo Luna, Sole, stelle, o galassie, ma un multiverso infinito. E, allora, quale futuro ci aspetta in un mondo di infinite possibilità? Su questo deve oggi riflettere l’artista, non più su nature morte o paesaggi, che pure fanno parte del DNA di ogni artista, ma sul micro e macro cosmo che ogni giorno ci svela nuovi segreti ai limiti della fantascienza. Come può l’artista rinunciare a raccontarsi in questo nuovo mondo?»
Così si interroga Franco Bulfarini, quando gli chiediamo quale ruolo debba avere oggi l’artista.
Bulfarini non vive in una torre d’avorio, non è l’artista stereotipato nel viandante isolato dal mondo, ma è fortemente ancorato al proprio tempo, tempo che esamina con occhio critico e una mente sagacemente filosofica. Infatti, rivendica per l’artista un ruolo attivo e dialogante con la società.
In un mondo dominato dalle “protesi dell’Intelligenza Artificiale”, dalla robotica e dalle scoperte della meccanica quantistica, Bulfarini sceglie la via della tradizione innovativa.
Non serve la pittura digitale per essere avanguardisti, non servono nuovi strumenti tecnologici e digitali, ma bastano spatole e pennelli, purché si sappiano affrontare concetti nuovi e attuali, che sappiano far riflettere.
L’arte deve essere lenta, riflessiva e costruttiva, dice l’artista. Se la società corre veloce verso scoperte che rompono dogmi secolari, l’artista ha il dovere di raccontare questo nuovo mondo di infinite possibilità.
E Franco Bulfarini agisce come un catalizzatore di emozioni, trasformando la materia in spirito per condurre il fruitore in un viaggio meraviglioso.
UN DONO PER IL PROSSIMO: IL SENSO DELLA MOSTRA
Esporre a Sassuolo è un’opportunità di scambio umano e intellettuale.
L’artista ci spiega: «Perché fare arte? Penso che per tutti i veri artisti, la si faccia nell’intento di scovare qualcosa di buono in noi da lasciare in eredità ai fruitori, nella speranza di creare in loro una comunicazione emozionale, un dialogo e una crescita valoriale ed emotiva. Come sosteneva Paul Klee, – che ho sempre ammirato, – “L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile”. Questo è per me lo scopo dell’arte.»
D’altronde, Picasso e altri sostenevano che “l’artista non può limitarsi”. Chi fa Arte con la A maiuscola lo fa per dialogare con il mondo, per comunicare uno o più messaggi, non certo per creare oggetti d’arredo che piacciano per la loro bellezza.
Le opere di Bulfarini, come ammette lo stesso artista, sono come figli, sono nate da una fatica introspettiva, e prendono la propria strada per diventare compagne di viaggio di chi saprà contemplarle con amore e con la capacità di riflettere.
Lo scopo ultimo è rendere visibile l’invisibile, portando alla luce ciò che è celato sotto la superficie opaca del quotidiano. È un’arte del risveglio che ambisce a lasciare qualcosa di buono nella società, promuovendo una crescita valoriale ed emotiva.
In fondo, Franco Bulfarini dipinge per dare colore non solo alla propria vita, ma a quella di tutti noi.
Prossimamente, un articolo specifico sulla mostra e sulla critica alle opere dell’artista.
DETTAGLI DELLA MOSTRA
TITOLO DELLA MOSTRA: FIGURAZIONE AVVENIRISTICA E CITTÀ IMPOSSIBILI
ARTISTA: FRANCO BULFARINI (BULFARTE)
INDIRIZZO: GALLERIA D’ARTE “JACOPO CAVEDONI”, VIA FENUZZI 12/14, SASSUOLO (MO)
DATE: DAL 24 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026
VERNICE: SABATO 24 GENNAIO 2026, ORE 16:30
INTRODUZIONE CRITICA: DOTT. PASQUALE DI MATTEO
ORARI DI APERTURA: VENERDÌ, SABATO E DOMENICA (10:30/12:30 – 14:30/18:30)
FINISSAGE: MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO (10:30/12:30)
CONTATTI: bulfarte@gmail.com
INGRESSO: LIBERO E GRATUITO