Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso i confini dell’Europa orientale e le dinamiche del Medio Oriente, si sta perpetrando una trasformazione radicale e silenziosa che sta ridisegnando la grammatica del potere sul pianeta.
È un conflitto che si percepisce appena, annunciato dal pericoloso scricchiolio dei ghiacciai che si ritirano.
L’Artico è diventato il nuovo scacchiere del XXI secolo. Qui, dove il freddo e la solitudine di spazi incontaminati dovrebbero imporre il silenzio, il rumore degli interessi geopolitici è assordante.
OLTRE IL MITO DEL PASSAGGIO A NORD-OVEST
Il leggendario Passaggio a Nord-Ovest, un tempo sogno proibito degli esploratori, oggi rappresenta una realtà commerciale che fa tremare le vecchie rotte.
La geografia sta cambiando pelle. Entro il 2040, l’oceano artico sarà ampiamente navigabile, aprendo autostrade d’acqua che riducono le distanze tra Amburgo e Shanghai di oltre il 40% rispetto al Canale di Suez.
Ma questo cambio geografico non è solo una questione di logistica, ma rappresenterà un terremoto economico. La rotta marittima settentrionale è un’arma geostrategica che la Russia sta già affilando con la sua flotta di rompighiaccio nucleari, come la mastodontica Sevmorput, l’unica nave portacontainer nel mondo a propulsione nucleare.
Tuttavia, Mosca non è sola in questa scalata. Pechino, autoproclamatasi “Stato vicino all’Artico” con un’audacia semantica che mette a dura prova la geografia, ha già tracciato la sua “Via della Seta del Ghiaccio”.
IL NUOVO GOLFO PERSICO: UNA RICCHEZZA CHE BRUCIA
Le stime sono da capogiro: il 13% del petrolio e il 30% del gas naturale non ancora scoperti si troverebbero sotto il permafrost, quello strato di terra o di rocce lasciate a una temperatura pari o inferiore a 0°C per almeno due anni consecutivi, di cui sono ricche le regioni polari.
Ecco perché l’Artico è diventato, a tutti gli effetti, il nuovo Golfo Persico.
Ma la vera partita non si gioca solo sul greggio. La Groenlandia, un gigante di ghiaccio sette volte più grande dell’Italia, ma popolato quanto un capoluogo di provincia, nasconde nel suo sottosuolo il 25% delle terre rare mondiali.
Questi minerali sono indispensabili nelle tecnologie verdi e nella difesa missilistica, poiché senza, la transizione ecologica sarebbe solo un castello di carta.
Gli Stati Uniti, con un ritardo strategico grave e colpevole, stanno cercando di recuperare il terreno perduto, a qualunque costo. Anche scatenando una guerra mondiale.
L’interesse quasi ossessivo di Donald Trump per l’acquisto dell’isola non è un capriccio immobiliare, ma una mossa di sopravvivenza industriale e, probabilmente, l’unica via rimasta per evitare di subire il sorpasso della Cina in tempi brevi.
LA SPORCA VERITÀ DELLA RAFFINAZIONE
Eppure, in questo gioco di geopolitica che va ben oltre Il Risiko, c’è un segreto che l’Occidente fatica ad ammettere.
Il vero potere della Cina non è il possesso delle materie prime, ma si trova tutto nel monopolio della loro raffinazione.
Infatti, Pechino controlla il 70% del mercato globale delle terre rare perché ha accettato di fare il “lavoro sporco”, quello che altri paesi non vogliono fare perché significa mandare in soffitta le politiche green e i loro parametri.
Raffinare questi minerali significa devastare l’ambiente e ignorare i diritti umani, standard che le democrazie liberali non possono o non vogliono sostenere.
L’idea di trasformare la Groenlandia in una “mini-Cina” risponde a un cinismo spaventoso, ma è anche di una logica spietatamente geniale, per cui gli USA sposterebbero l’inquinamento e lo sfruttamento in un giardino di casa controllato, pur di spezzare la catena di dipendenza da Pechino.
È la fine dell’ipocrisia geopolitica. Perché il giardino di casa americano non è più una prateria ordinata, ma una giungla dove la sopravvivenza impone scelte brutali, compreso l’uso della forza militare per ottenere ciò che esige l’impero.
OMBRE SUL PERMAFROST: IL COSTO UMANO DEL PROGRESSO
In questa corsa all’oro bianco, c’è chi non ha voce. Non si tratta solo del Diritto internazionale, che gli americani prendono a calci da decenni (Iraq, Jugoslavia, Libia…), salvo pretenderne il rispetto da Mosca, ma si tratta anche del popolo Sami e delle comunità indigene artiche, che vedono i loro pascoli di renne trasformarsi in basi militari e siti estrattivi.
Proprio come in uno di quei film d’azione americani, dove, tuttavia, i cattivi sono sempre privati cittadini a capo di organizzazioni criminali, mentre qui, nella realtà del mondo di oggi, i cattivi sono gli uomini al comando del potere politico.
Intanto, il governo americano prosegue la militarizzazione della zona, tra test missilistici e satelliti Starlink utilizzati come occhi nel gelo, senza consultazioni.
L’Artico viene raccontato come una terra di nessuno, ma, in realtà, sembra già tra le grinfie dell’impero. Un ecosistema fragile, per cui un errore di calcolo può significare un disastro ambientale irreversibile per l’intero pianeta. Rischio che gli americani non hanno nessuna intenzione di prendere in esame, attenti solo ai propri interessi nazionali.
L’EREDITÀ DI SEWARD E IL DESTINO DELL’OCCIDENTE
Nel 1867, l’acquisto dell’Alaska fu liquidato come la “follia di Seward”.
Oggi, quel milione e mezzo di chilometri quadrati garantisce agli Stati Uniti un posto al tavolo dei grandi dell’Artico. La storia è un cerchio che si chiude.
La sfida tra Washington e l’asse Mosca-Pechino non si risolverà probabilmente con una guerra aperta, ma con una battaglia di logoramento commerciale e tecnologico. La posta in gioco è l’autonomia del prossimo secolo.
Se l’Europa non sarà in grado di sviluppare una strategia artica integrata, che unisca difesa, economia e rispetto per le popolazioni locali, si ritroverà spettatore di un mondo dove il ghiaccio si è sciolto per lasciare spazio a un’egemonia asiatica.
L’Artico è lo specchio del nostro futuro: freddo, conteso e terribilmente fragile, dove la Cina controlla i minerali e la loro raffinazione, mentre gli USA cercano disperatamente di non perdere il controllo dei flussi di energia.
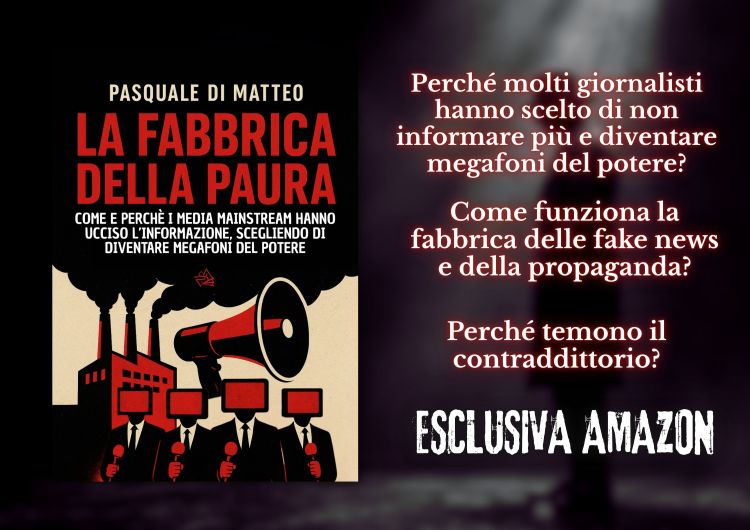

Dott. Pasquale Di Matteo
Giornalista freelance, esperto di Politiche Internazionali ed Economia, Comunicazione e Critica d’arte. Laureato in Scienze della Comunicazione, con un Master in Politiche internazionali ed Economia, rappresenta in Italia la società culturale giapponese Reijinsha.Co.




























