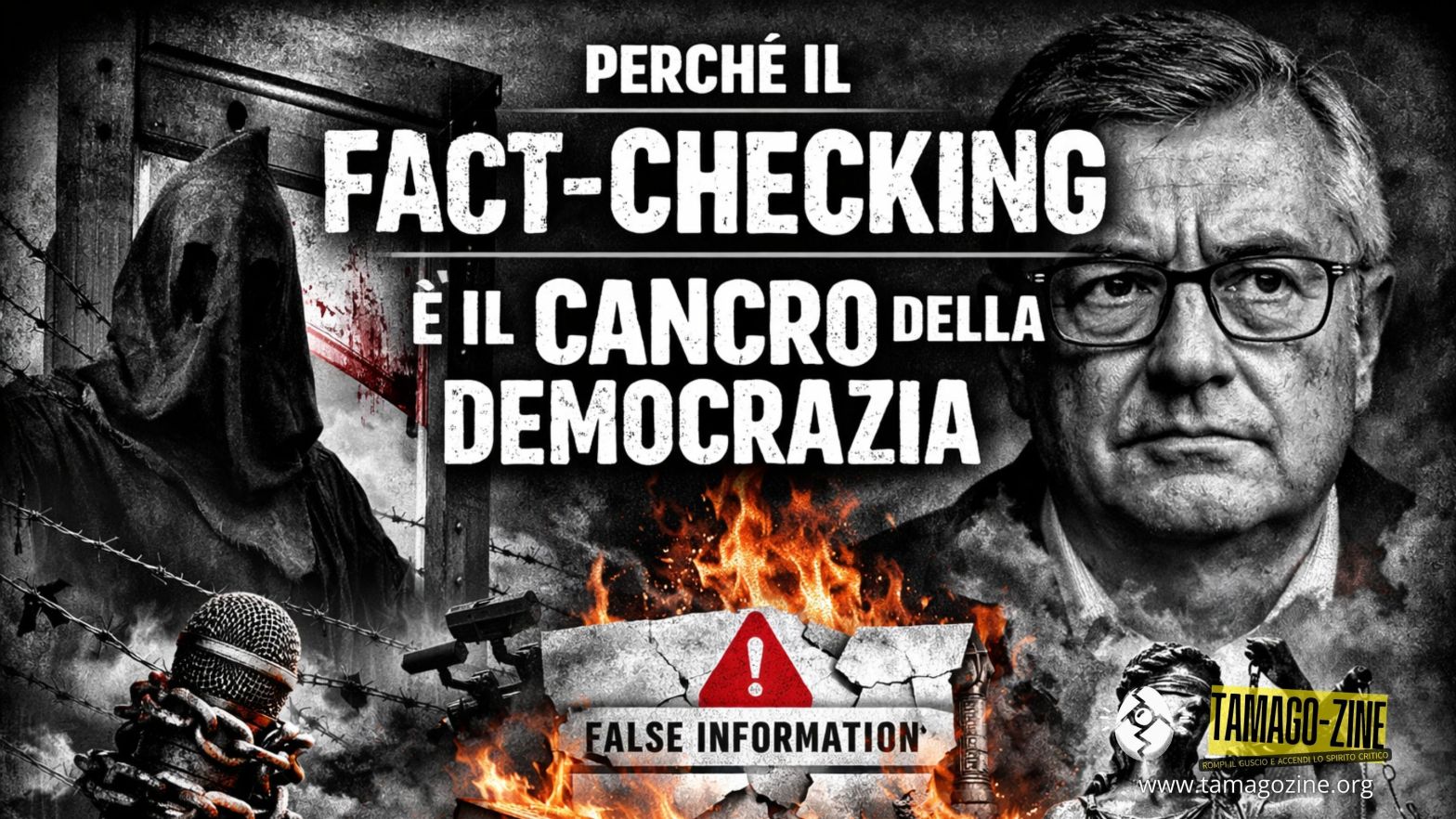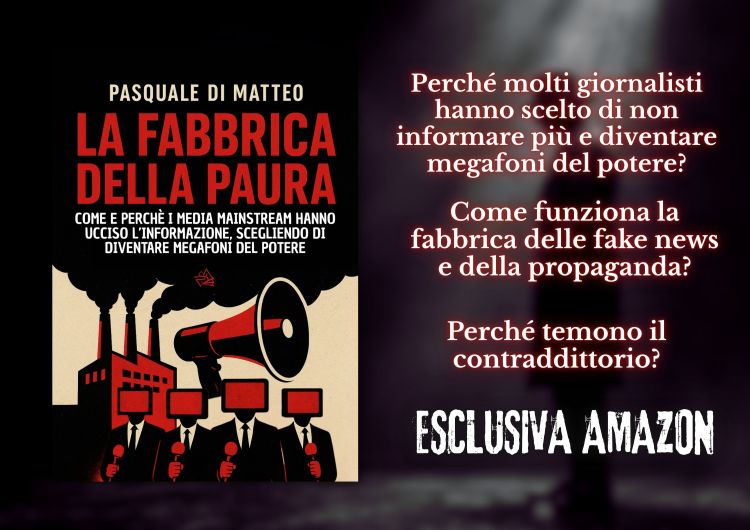Il silenzio non fa rumore, ma ha un peso specifico insostenibile, soprattutto quando un algoritmo, addestrato e/o coordinato da redazioni che confondono l’inchiesta con l’obbedienza agiscono a favore dei pensieri unici.
Perché quando l’obbedienza decide di soffocare la voce di Alessandro Barbero non lo fa semplicemente per correggere un’imprecisione tecnica, che al limite si corregge con un articolo, un video, una precisazione, ma compie un atto di eugenetica intellettuale e ci pone dinanzi alla ghigliottina invisibile del XXI secolo, dove il boia indossa la maschera rassicurante del “verificatore” per nascondere il volto del censore.
Ma verificatore di cosa, con quali competenze, in nome di quale norma e per conto di chi?
Alessandro Barbero non è solo uno dei più importanti storici in circolazione, ma è un connettore tra la complessità del sapere e la cittadinanza, grazie a una grande notorietà, ed è questo che spaventa il sistema.
Ridurre un suo ragionamento di venti minuti a un “bollino rosso” per un dettaglio procedurale sul sorteggio delle liste del CSM è un’operazione di una disonestà intellettuale abbacinante.
È come censurare un’intera sinfonia di Beethoven perché una singola nota è stata suonata con un’intonazione diversa da quella prescritta da un comitato di quartiere.
Ma il punto non è l’errore, o presunto tale. Il punto è la sovranità dell’opinione.
In una democrazia degna di questo nome, il fact-checking applicato al pensiero politico dovrebbe essere vietato per legge per un’evidenza logica che persino un bambino saprebbe cogliere: non esiste, né può esistere, un arbitro imparziale nel campo delle idee.
La verità, nelle scienze sociali, nel diritto e nella politica, non è un dato cristallino da laboratorio, ma un campo di tensioni, una dialettica perenne tra interpretazioni conflittuali.
Affidare a una società privata, o a una testata partner, il potere di stabilire cosa sia “vero” significa istituire un tribunale dell’inquisizione digitale che non risponde a nessuna Costituzione, se non al bilancio dei propri azionisti e ai desiderata del potere che comanda.
Abbiamo già visto questo film, ed era un horror. Durante la pandemia, abbiamo assistito allo spettacolo grottesco di fact-checkers che a malapena padroneggiavano una laurea triennale intenti a “smentire” e silenziare premi Nobel per la medicina, medici di chiara fama e docenti universitari con decenni di ricerca alle spalle.
E, grazie alle ammissioni di Mark Zuckerberg, sappiamo che tali censure erano state richieste dall’Amministrazione Biden.
Tanti esperti e luminari in materie mediche sono stati trattati come ciarlatani perché le loro analisi non baciavano il deretano del pensiero unico dominante.
E sarà ancora peggio in futuro, quando tali servizi saranno affidati a Intelligenze Artificiali, istruite da non si sa bene chi e con quali scopi, con quali istruzioni.
Allora, si potrebbe spacciare per vera la notizia delle sanzioni dirompenti, delle quattro tipologie di cancro di Putin, dei droni russi in Estonia e altre notizie che oggi sappiamo essere fake news: le sanzioni non hanno avuto gli effetti su Mosca che ci raccontavano; Putin non è morto per il cancro e i droni sull’Estonia erano ucraini.
E se qualcuno avesse interesse a non aggiornare le AI e mantenesse la notizia dei droni russi e del cancro di Putin?
Il fact checking è la vittoria del Dunning-Kruger elevato a sistema di governo, è l’incompetenza che, forte di un algoritmo, si fa dogma e zittisce l’eccellenza.
Chi si batte ogni giorno contro la disinformazione, come facciamo noi di Tamago, non chiede la censura, ma argomenta e dimostra nei fatti il perché qualcuno ha veicolato una fake news.
Infatti, non abbiamo mai chiesto di silenziare La Repubblica, Il Corriere della Sera, i TG della RAI e altri media perché negli ultimi cinque anni ci hanno raccontato panzane su green pass che servivano a creare luoghi sicuri, vaccini che evitavano di contagiare, controffensive ucraine, muli usati al posto dei mezzi corazzati, microchip smontati dalle lavastoviglie, pale dell’800, Putin affetto da almeno quattro tipologie di cancro, sanzioni dagli effetti dirompenti che avrebbero piegato Mosca in pochi mesi e altre sciocchezze.
Le abbiamo smascherate facendo notare la verità sancita dal tempo e dai fatti. Poi sta ai cittadini rendersi conto di chi fidarsi e di chi è meglio lasciare solo, con i propri abbonati.
Al contrario, se un fact-checker può limitare la portata di un Barbero oggi, senza un contraddittorio e senza avere competenze specifiche della materia trattata, né una cultura almeno pari a chi viene censurato, chiunque domani potrà essere ridotto al silenzio.
È una tattica di contenimento del dissenso che opera per erosione. Si inizia colpendo il “dettaglio” per screditare l’insieme.
Si prosegue riducendo la visibilità per spegnere il dibattito. Si finisce per indurre l’autocensura, che è la forma più subdola e letale di dittatura, perché il cittadino medio, vedendo il bollino di avvertimento, non approfondisce; percepisce solo un segnale di allerta, un odore di “pericolo” associato a una voce critica.
IL FACT-CHECKING È L’ANTITESI DELLA LOGICA
La democrazia esiste se le idee sono libere, non se il consenso è endemico. Se eliminiamo il rischio del “falso”, eliminiamo la possibilità stessa del dubbio e trasformiamo la democrazia in un’altra cosa.
Ma chi decide cos’è falso? La storia ci insegna che le grandi verità di oggi sono state le eresie di ieri.
Se il fact-checking fosse esistito nel 1600, Galileo Galilei sarebbe stato bannato da ogni piattaforma per “disinformazione flagrante” contro il consenso astronomico dell’epoca.
Oggi non bruciamo più i corpi, ma bruciamo la reputazione e la portata del messaggio, che in un’era digitale è l’equivalente della morte civile.
Queste piattaforme multinazionali agiscono ormai come Stati sovrani, ma senza il fardello della responsabilità democratica, perché controllano lo spazio pubblico in cui si forma la coscienza politica dei cittadini, ma applicano regole opache, dettate da interessi geopolitici ed economici che nulla hanno a che fare con la ricerca della verità.
Ma agiscono fidandosi di servizi di fact checking locali, assecondando le loro indicazioni, per non inimicarsi i governi locali, in modo da continuare a godere delle fortissime agevolazioni fiscali di cui godono.
La pretesa di Meta di “proteggere l’utente” è un insulto all’intelligenza collettiva. È un paternalismo autoritario che presuppone un popolo di idioti, incapaci di filtrare, criticare e scegliere tra diverse tesi.
IL BANDO DEL DISSENSO E IL TRIONFO DEL NULLA
Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: il fact-checking non serve a proteggere la verità, serve a proteggere il potere. Serve a garantire che il “pensiero unico” non venga incrinato da chi ha gli strumenti intellettuali per smontarlo pezzo dopo pezzo.
Barbero fa paura perché è popolare e colto. Molto, troppo più colto dei fact checkers, che, spesso, non hanno neppure una triennale.
Fa paura perché spiega che la giustizia è una questione politica, non un tecnicismo per iniziati. Fa paura perché il suo “No” è argomentato, storico, profondo, incompatibile con l’inadeguatezza culturale degli stessi fact checkers.
Fa paura perché ha una cultura immensa rispetto al tizio che lo ha “censurato”, insomma.
È giunto il momento di smantellare questo apparato di sorveglianza cognitiva. La libertà di espressione non può essere soggetta a un “visto” preventivo o a una sanzione postuma basata su criteri soggettivi mascherati da oggettività.
Se permettiamo che il fact-checking diventi la norma, accettiamo di vivere in una democrazia a bassa risoluzione, dove i colori del dissenso sono sbiaditi da un filtro cupo di conformismo forzato.
Non lasciamo che il “click” di un burocrate digitale spenga la luce della ragione. La verità non ha mai bisogno di guardiani, ma di aria, di scontro e, soprattutto, di libertà.
E lo dimostra il fatto che i soliti fact checkers non hanno mai avanzato dubbi quando Draghi parlava di basi scientifiche nonostante quelle basi non esistessero, come sapevamo in tanti e come il tempo e i fatti ci hanno confermato.
Il fact checking è un’attività che non ha alcuna ragione logica di esistere in una democrazia, ma che è tifata da tanti che nei confronti della democrazia nutrono una profonda idiosincrasia.