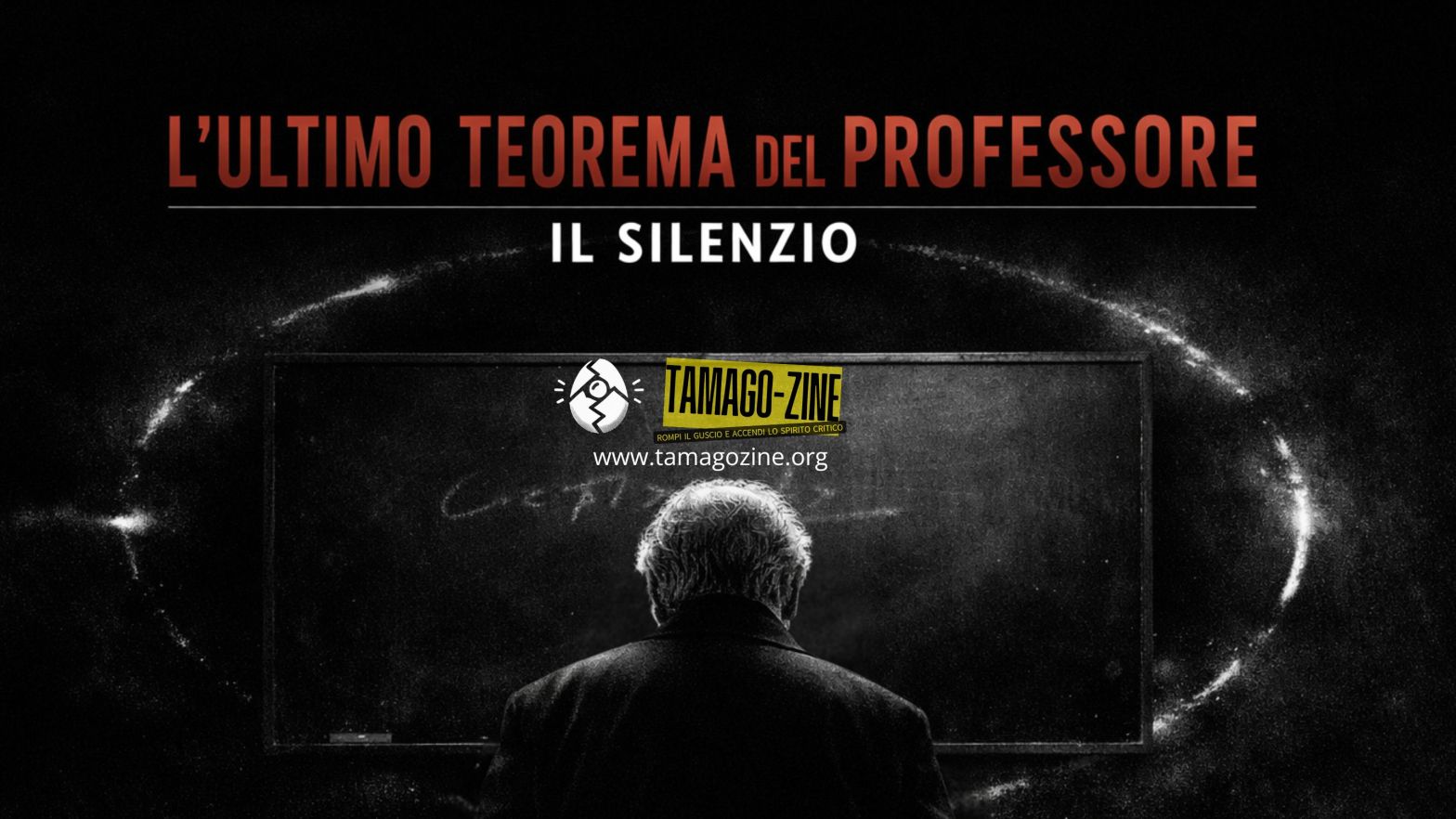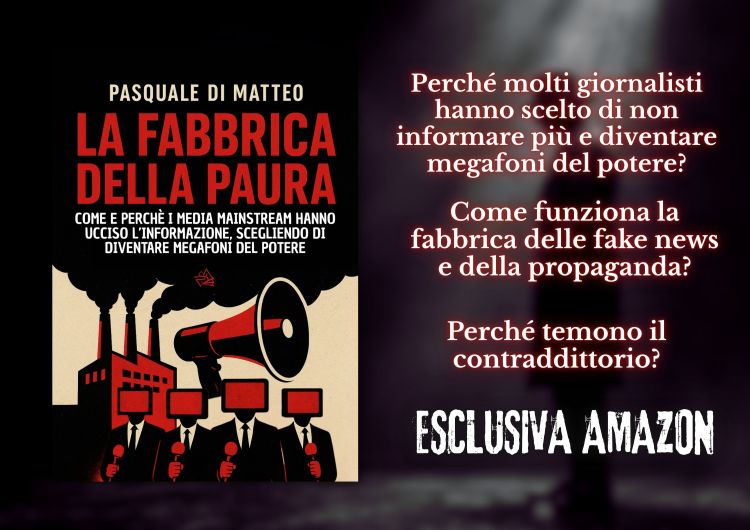Il silenzio che ha lasciato è un’onda d’urto, un boato sordo che si propaga dai laboratori del CERN fino alle cucine delle case popolari, perché Antonino Zichichi non era solo un fisico.
Era un pezzo d’Italia. Certo, i più giovani non l’hanno conosciuto, ma chi ha qualche primavera in più sulle spalle ricorderà che era una di quelle presenze che si danno per scontate, come i lampioni che si accendono al crepuscolo o il sapore del caffè al mattino, e che solo quando spariscono ti accorgi del buco nero che lasciano.
A 96 anni, il professore ha smesso di calcolare, di polemizzare, di cercare. E di illuminarci.
Era l’uomo che aveva visto l’antimateria. L’aveva guardata in faccia nel 1965 con il suo gruppo di ricerca, quando s’imbatté nell’antideutone. Un’inezia per i più, un ghirigoro incomprensibile su una lavagna. Ma per lui era la prova che l’universo è un mistero più grande e spaventoso di quanto le nostre piccole menti possano contenere.
Zichichi era un cacciatore di fantasmi subatomici, un esploratore dell’infinitamente piccolo che sognava l’infinitamente grande. E lo faceva con la foga di un ragazzino e la protervia di chi sa di avere ragione, anche quando tutti gli altri dicono di no, ridono, sbeffeggiano e scuotono la testa.
ERICE, O IL MONDO IN UNA STANZA
C’è un posto in Sicilia, aggrappato a una montagna come un nido d’aquila che si chiama Erice. Un labirinto di pietre medievali dove il vento sibila storie antiche. Lì, in quel luogo fuori dal tempo, Zichichi ha dato casa al Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana”, nel 1963, quando l’Italia pensava ad altro.
Un seme che ha trascinato in quel borgo sperduto migliaia di scienziati, premi Nobel con le camicie stropicciate e giovani geni con gli occhi pieni di futuro.
Ha trasformato Erice nel confessionale del mondo scientifico, un luogo dove le menti più brillanti del pianeta potevano spogliarsi dei loro titoli e parlare, litigare, sognare la prossima frontiera della Scienza, quella con la S maiuscola e non quella delle lobby e dei pensieri unici.
Ma non si è fermato a quello, infatti ha voluto una cattedrale sotterranea per la fisica, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Un’idea folle, visionaria. Un’idea che oggi è uno dei gioielli della ricerca mondiale.
Perché Zichichi non si limitava a studiare la realtà, ma la piegava, la plasmava con la forza di una volontà che non conosceva ostacoli. Era un costruttore, non solo un teorico. Un siciliano testardo che ha portato il mondo nella sua isola e ha mostrato all’Italia che poteva, che doveva, osare.
LA CROCE E L’ACCELERATORE
E poi c’era Dio.
La sua non era una fede sussurrata, intima. Era un grido, un postulato messo in cima a ogni equazione.
Per Antonino Zichichi, scienza e fede non erano rette parallele destinate a non incontrarsi mai, ma la stessa cosa, due facce della stessa medaglia divina.
“La Scienza è un atto di fede in Colui che ha fatto il mondo”, ripeteva come un mantra, con quella sua cadenza inconfondibile che bucava lo schermo televisivo.
In un mondo accademico che spesso guardava alla religione con sufficienza, lui brandiva la sua croce come una spada, vedeva l’impronta del Creatore nell’eleganza delle leggi fisiche, anche se era un’idea di Creatore del tutto diversa da quella biblica o di altre religioni.
La sua fu una semiotica della certezza in un’epoca liquida, portata avanti con un messaggio semplice, e per questo potente, che lo rese immensamente popolare, ma che gli attirò anche il disprezzo di una parte della comunità scientifica, che lo vedeva come un predicatore travestito da scienziato.
Ha combattuto la sua battaglia contro quella che chiamava “l’Hiroshima culturale”: l’astrologia, la superstizione. Un nemico facile, forse, per uno scienziato, ma lui lo affrontava con la stessa serietà con cui dava la caccia a una particella sfuggente, perché, per lui, confondere la scienza con la magia era il peccato originale, la bestemmia più grande contro la ragione e, in ultima analisi, perfino un atto contro Dio per chi era credente.
L’ERETICO NELLA CATTEDRALE
Zichichi era anche un contestatore, un eretico nella cattedrale della scienza ufficiale, una spina nel fianco dei pensieri unici.
La sua negazione dell’evoluzionismo darwiniano era leggendaria, quasi un affronto personale a Darwin. La liquidava come una teoria senza prove, un “atto di fede” a cui lui non era disposto a credere.
Una posizione che lo isolò, che lo rese un bersaglio, ma che fondava su prove evidenti, perché l’uomo è l’unica specie al mondo che non segue le regole basiche di tutte le altre, che non si adatta fisicamente all’ambiente in cui vive.
E poi, il clima. In un mondo che iniziava a urlare per l’emergenza ambientale, lui restava scettico, dubitava dei modelli matematici, diffidava di un allarmismo che considerava più politico che scientifico.
Per questo diventò scomodo. Terribilmente scomodo.
La sua carriera è stata costellata da questi scontri frontali, da queste rotture violente. Come quella volta, nel 1979, quando la sua corsa a direttore del CERN, il tempio della fisica europea, fu silurata con un gioco di veti incrociati che sapeva più di Guerra Fredda che di libera scienza.
Fu una ferita profonda, un rigetto da parte di quel mondo che lui aveva tanto contribuito a costruire, ma che non era disposto a staccarsi dal potere politico e da certi salotti del pensiero.
Ora il professore tace e non contesterà più.
La sua voce tonante non tuona più dai talk show.
Tuttavia, resta l’eco delle sue certezze e dei suoi dubbi. Restano il granito del Gran Sasso e le pietre antiche di Erice.
Resta l’immagine di un uomo che ha cercato la firma di Dio nel cuore dell’atomo, un grande scienziato che ha avuto l’umiltà e la saggezza di non smettere mai di usare il pensiero critico e il merito di non piegarsi mai ai pensieri unici o al potente di turno.
Un gigante della Scienza complesso, divisivo, geniale e forse, proprio per questo, irrimediabilmente umano.
Il suo ultimo esperimento è concluso. E noi siamo qui, nel silenzio, a interrogarci sul risultato, spaventati come bambini perché non vediamo altri giganti come Zichichi all’orizzonte.
IL RICATTO DI KIEV E IL PARADOSSO DI UN’EUROPA OSTAGGIO
Mentre Kiev stringe i rubinetti dell’oleodotto Druzhba, l’Europa scopre il prezzo di un’alleanza trasformata in assedio. Dalle minacce alle agenzie anti-corruzione al miraggio di una controffensiva fantasma, aumenta il rischio di un coinvolgimento diretto della NATO, nel paradosso economico di un continente che finanzia la sua stessa sottomissione.
L’ANATOMIA DEL CROLLO AMERICANO E IL NUOVO CAOS MONDIALE
L’illusione della stabilità globale è finita. Tra lo schianto del sogno americano, la guerra di logoramento in Ucraina e il nuovo scacchiere energetico dell’Artico, stiamo assistendo alla mutazione genetica della geopolitica.
L’ANNO DELLO SCOSCENDIMENTO
L’8 febbraio 2026 il Giappone ha smesso di essere un paese con una maggioranza fragile. 317 seggi. Potere assoluto. Sanae Takaichi ora può tutto. Ma il paradosso del potere totale è che toglie ogni alibi. Mentre lo yen affonda, gli anziani restano soli e i giovani non votano, la prima donna premier scopre che vincere…