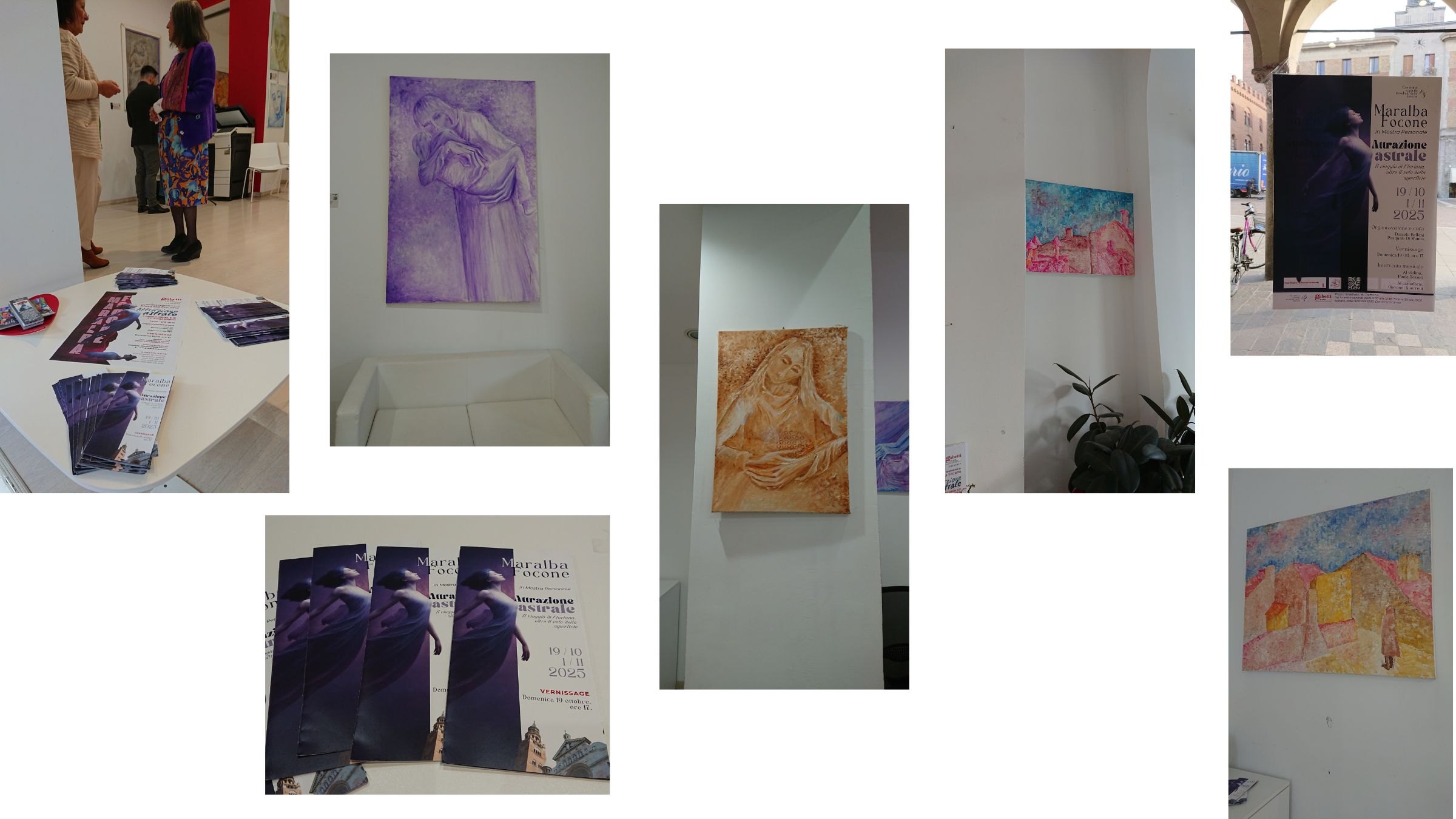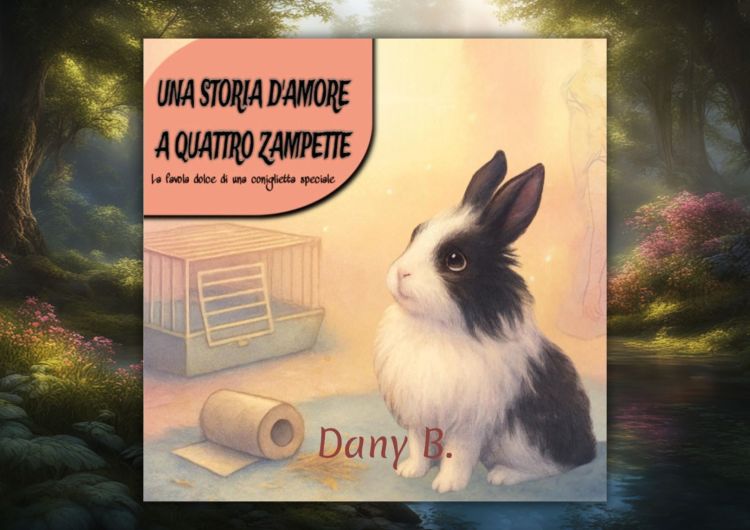Non serve un microscopio per analizzare il cadavere della partecipazione democratica in Italia; basta guardare i numeri delle amministrative.
Nelle regioni chiamate al voto, Campania, Veneto e Puglia, il vero trionfatore non ha volto, non ha simbolo e non ha comizi. Non è di centro, di sinistra o di destra. È il Partito dell’Astensione.
Un gigante silenzioso che ha divorato la legittimità delle istituzioni, che rappresentano solo una minima parte degli italiani.
In Campania, si è presentato ai seggi un misero 44,06% degli aventi diritto. Un crollo vertiginoso dell’11,5% rispetto al 2020. Il Veneto, un tempo roccaforte della partecipazione civica, ha risposto con un’alzata di spalle ancora più netta: 44,64%, lasciando sul terreno oltre 16 punti percentuali. La Puglia segue a ruota, fermandosi al 41,83%.
Il Partito dell’Astensione ottiene tra il 56 e il 59% dei voti. Un plebiscito che indica come i vincitori di questa tornata elettorale rappresentino soltanto un italiano su quattro, spesso addirittura meno.
Il 60% di Fico, ma sul 44% di campani aventi diritto, indica che il nuovo governatore è stato votato da un campano su quattro. Il suo risultato reale è il 26,4% degli aventi diritto.
Stesso discorso vale per gli altri “vincitori” di queste elezioni.
Non è solo un’anomalia statistica, ma un cancro che ha già metastatizzato in Valle d’Aosta, Marche, Calabria e Toscana, dove le percentuali di affluenza sono scivolate inesorabilmente verso il basso, con picchi negativi che sfiorano i 15 punti percentuali di emorragia. L’astensione non è più soltanto un segnale d’allarme, ma la normalità.
DAL VOTO DI OPINIONE AL VOTO DI RELAZIONE: LA FINE DELL’IDEOLOGIA
Le elezioni politiche o europee sono il regno dell’astrazione: si vota un simbolo, una visione, talvolta un risentimento. Il più delle volte, si vota qualcuno per non votare l’altro. Si vota per tifo familiare.
È un voto “di pancia” più che “di testa”.
Alle amministrative non si vota l’ideologia, o, almeno, non si dovrebbe. Si dovrebbe scegliere la “persona”, il volto noto, l’amico dell’amico, il cugino, il professionista che ti ha stretto la mano al bar.
In teoria, questo dovrebbe essere il sale della democrazia rappresentativa: il legame diretto, il controllo immediato, la possibilità per il cittadino di guardare negli occhi l’eletto e chiedergli conto del suo operato.
Dovrebbe.
Ma la realtà è che questo meccanismo si è inceppato da tempo.
Il consigliere locale, un tempo cinghia di trasmissione tra i bisogni del territorio e l’amministrazione, è diventato un simulacro.
Privo di una vera visione del mondo, o pronto a tradirla per un salto della quaglia verso partiti opposti pochi giorni dopo l’elezione, il politico locale non trasforma più il territorio, ma si limita a occuparlo per il partito di appartenenza.
LA CRISI DEL CLIENTELISMO: QUANDO MANCANO LE BRICIOLE
Per decenni, il sistema ha retto su un patto tacito, spesso inconfessabile: il voto di scambio.
Non scandalizziamoci, siamo uomini di mondo. Il sistema clientelare, nella sua perversione, aveva una sua efficienza funzionale, perché il voto garantiva una “pagnotta”. Un posto di lavoro, una licenza, un piccolo appalto.
Oggi, questo meccanismo si è rotto per un motivo puramente economico: la cassa è vuota. Non ci sono più soldi. Non c’è più grasso che cola.
Le amministrazioni locali sono state svuotate di potere reale. Le decisioni strategiche non si prendono nei consigli comunali, ma in Europa, nelle commissioni tecniche, nei board finanziari sovranazionali.
Il politico locale non è più il fornaio che distribuisce il pane, ma è diventato un cameriere che non ha nemmeno accesso alla cucina.
Il voto non si scambia più con un favore reale, ma con la *speranza* di un favore futuro che, con ogni probabilità, non arriverà mai.
Il grande appalto del PNRR o la riqualificazione urbanistica diventano miraggi per tenere l’elettore incatenato in uno stato di perenne attesa, una forma di schiavitù psicologica: l’uomo che dipende dalla promessa di un altro uomo non sarà mai davvero libero.
E l’elettore, stanco di essere preso in giro, ha smesso di credere alla favola. Ha smesso di esprimere un voto per qualcuno o per un partito che sa già che, alla fine, disattenderà le promesse e governerà come chi c’era prima o come avrebbe fatto il suo avversario, perché a decidere l’agenda politica è l’Europa e i politici italiani, dal sindaco del piccolo borgo al Presidente del Consiglio, sono passacarte e meri esecutori.
La gran parte degli italiani l’ha capito e vota in massa: vota per non votare.
Certamente, ci sarà qualche assenteista fisiologico. Nessuna nazione al mondo vanta il 100% di affluenza, ma la gran parte di chi non vota lo fa consapevolmente, per protesta.
IL TEATRO DELLE OMBRE: LA DEMOCRAZIA COME RITUALE SVUOTATO
Ciò a cui assistiamo è la trasformazione della democrazia in uno show costoso dove la sceneggiatura è già scritta. Cambiano i personaggi, ma le storie si ripetono. Come in una soap opera.
Non sono i cittadini a decidere. Il vero potere è in mano agli stakeholder, alle lobby, ai gruppi di interesse che muovono i fili dietro le quinte delle stanze del potere a Bruxelles.
Le elezioni sono diventate concorsi pubblici truccati, formalmente ineccepibili, sostanzialmente inutili.
E a vedere come Meloni governa, contrariamente alla sua campagna elettorale, tutto è dimostrato. Il PD deluse i propri elettori, poi il Movimento Cinque Stelle.
Non perché i politici italiani siano tutti incompetenti, ma perché non possono fare nulla di quanto promesso in campagna elettorale semplicemente perché non possono decidere nulla. Persino se inviare o non inviare armi in Ucraina è deciso dai ricatti dell’Europa.
E davvero credete che se un governo paventasse una lotta contro la Commissione europea, come cantava una delle promesse in campagna elettorale della Lega, per esempio, il Presidente della Repubblica non interverrebbe?
Nessun governo nazionale è libero di governare. Può soltanto amministrare e mettere in atto le decisioni di Bruxelles. Figuriamoci il governo di una Regione.
L’apparato democratico si regge ormai solo su inerzia, machiavellismo da quattro soldi e una narrazione mediatica sempre più scollegata dalla realtà.
Le maggioranze che escono dalle urne sono “bulgare” solo sulla carta, perché le percentuali sono tra chi ha votato. In realtà rappresentano una minoranza esigua della popolazione reale. Perciò, anche chi comanda non conta niente. Ha un potere vuoto. Finto.
Siamo governati da rappresentanti scelti da nessuno, che rispondono a logiche che nulla hanno a che fare con il bene comune.
Sono una finzione tenuta insieme con le graffette del buonsenso, ma che potrebbe essere spazzata via se solo il Partito dell’Astensione trovasse un leader capace di convogliare quella netta maggioranza del Paese.
VERSO UNA NUOVA CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Chi non va a votare non è un ignavo. Spesso è un attore razionale che ha compreso il gioco e ha deciso di non sedersi al tavolo, perché sa che le carte sono segnate. Sono truccate.
Si sa già chi deve vincere. Una volta destra, altre volte sinistra, ma l’agenda sarà quella. E se arriva un Savona a rompere il gioco, ci pensa il Presidente della Repubblica a ricordare che il voto sovrano degli italiani non è più sovrano se all’Europa non piace.
Chi resta a casa lo fa perché ha capito che non ci sono più “pagnotte” da spartire e che le relazioni personali, svuotate di potere economico e politico, non valgono il tempo di una domenica ai seggi.
Lungi dal fare moralismi da salotto, dobbiamo prendere atto di questo fenomeno con freddezza.
L’astensione di massa non è una malattia da curare con appelli accorati alla “responsabilità civica”, ma un sintomo terminale. Forse è arrivato il momento di smettere di recitare in questo teatrino.
Se la democrazia rappresentativa non riesce più a intercettare né gli ideali né gli interessi concreti, visto che non può farlo perché nessun politico è più libero di governare davvero, ha senso continuare a fingere di essere in una democrazia dove il popolo decide?
Potrebbe essere più onesto, e persino più efficace, togliere la maschera ipocrita del suffragio universale e immaginare nuove forme di gestione della res publica.
Magari attraverso una contrattualizzazione diretta degli interessi, assemblee specifiche, o sistemi che riconoscano la realtà delle forze in campo senza nascondersi dietro il velo pietoso di un’urna sempre più vuota.
Fino ad allora, il silenzio degli elettori continuerà a urlare più forte di qualsiasi comizio. E questo urlo, piaccia o no, è la cosa più vera che resta in questo Paese.
Nella speranza, o nella paura, che il Partito dell’Astensione non si renda conto della propria forza rivoluzionaria, l’unica che potrebbe ribaltare i tavoli del gioco e far scappare chi comanda davvero in Italia.
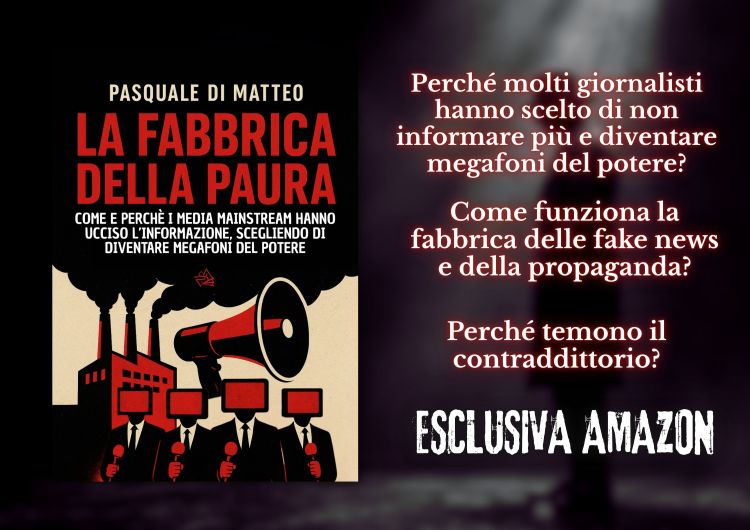

Dott. Pasquale Di Matteo
Giornalista freelance, esperto di Politiche Internazionali ed Economia, Comunicazione e Critica d’arte. Laureato in Scienze della Comunicazione, con un Master in Politiche internazionali ed Economia, rappresenta in Italia la società culturale giapponese Reijinsha.Co.