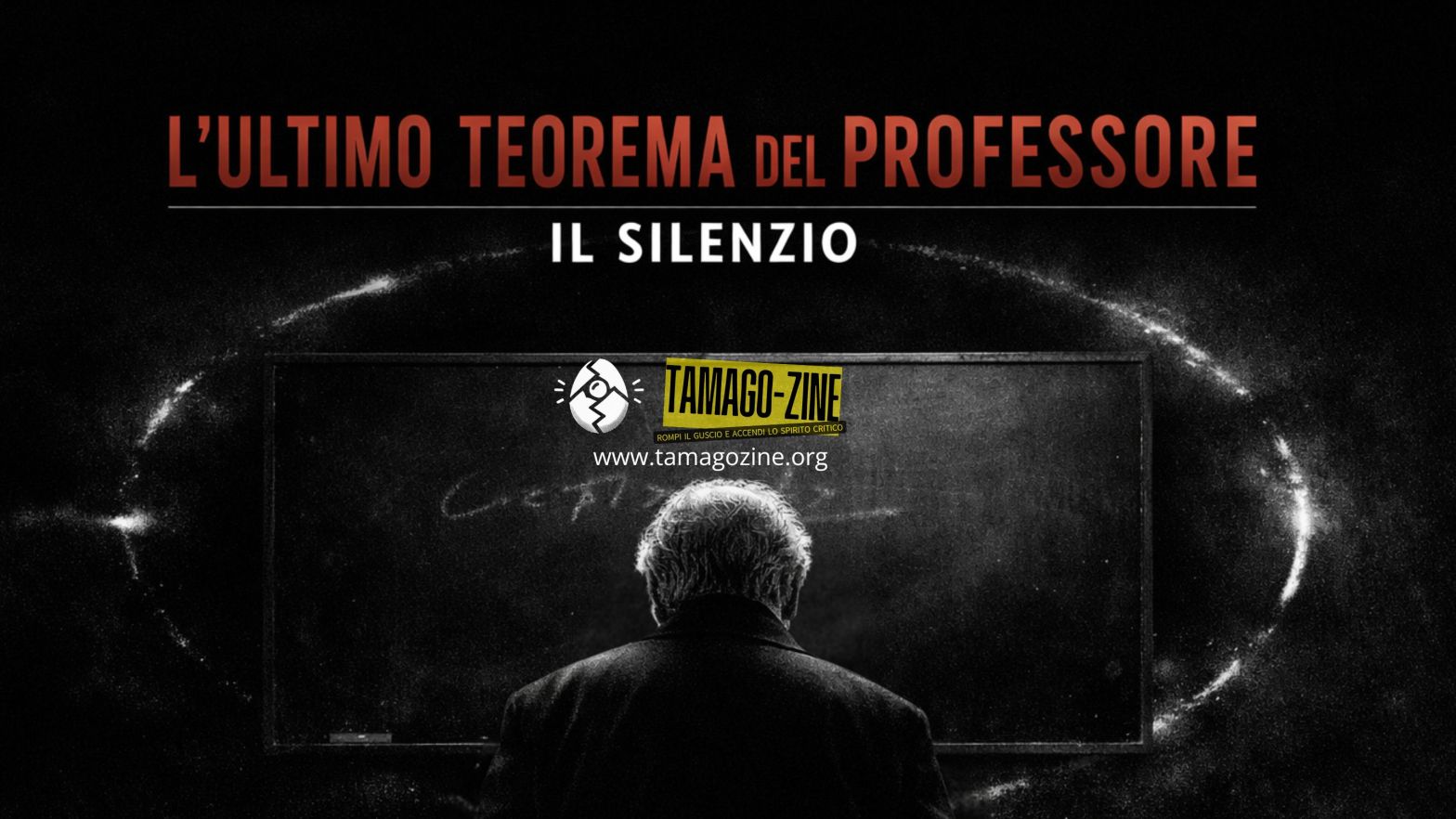OLTRE IL RECORD: UNA SUPER-MAGGIORANZA CHE PESA COME UN MACIGNO
Mentre Tokyo era coperta di neve, i giapponesi depositavano nelle urne qualcosa di molto più denso e persistente.
Il 56,26 per cento degli aventi diritto, due punti in più rispetto alla consultazione precedente, nonostante bufere che hanno imbiancato persino i santuari shintoisti di Asakusa, ha consegnato a Sanae Takaichi un mandato che non ha precedenti nella storia giapponese del dopoguerra a oggi.
Trecentoquindici seggi, poco più di centocinquanta oltre la soglia magica della maggioranza assoluta, oltre la fatidica linea dei due terzi che, nella grammatica costituzionale giapponese, significa avere la possibilità di riscrivere le regole del gioco.
La prima premier donna del Giappone, sessantaquattro anni, una frangia severa e il sorriso calibrato come un orologio Seiko, non ha vinto. Ha stravinto, e la domanda che ogni analista con un briciolo di onestà intellettuale dovrebbe porsi non è come abbia vinto, ma che cosa abbia realmente portato a casa, con questa vittoria.
E soprattutto: a quale prezzo.
LA COMUNICAZIONE DEL CONSENSO: QUANDO IL VOLTO DIVENTA MARCHIO
Sanae Takaichi sembra un artefatto semiotico perfettamente calibrato, infatti, non è la prima donna a guidare il Giappone per caso. È la prima donna a farlo perché ha saputo trasformare la propria identità di genere da ostacolo, considerata a lungo una debolezza, in un vantaggio competitivo devastante.
Takaichi non ha mai giocato la carta della donna contro il sistema, ma l’ha giocata dentro il sistema, piegando i codici del conservatorismo nipponico a proprio favore. Dove Shinzo Abe, suo mentore, imponeva autorità come un patriarca, Takaichi si pone con rassicurazione, con la prossimità della madre severa, ma giusta.
I sondaggi la danno vicina al settanta per cento di gradimento personale e, visti i risultati delle elezioni, non sbagliano affatto. Si tratta di un’anomalia statistica, in un Paese che ha visto premier logorarsi in pochi mesi quello che altrove si consuma in anni.
Tuttavia, il gradimento personale non è necessariamente consenso politico, ma qualcosa di più volatile, che interessa dinamiche più profonde. Diciamo che quella che i giapponesi riversano sulla loro premier è una fiducia più affettiva, quasi tribale.
Takaichi ha costruito questa fiducia con una strategia comunicativa che mescola tradizione, durezza e modernità, cioè, la frequenza nei santuari, l’uso calibrato del linguaggio onorifico, ma anche l’abbandono del tailleur rigoroso per indossare linee più morbide e i profili social. Tutto, mantenendo fermezza quando parla di Cina, di difesa, di identità nazionale.
Tre registri, un’unica voce che riesce a farsi sentire.
I caratteri kanji del suo nome, tracciati con pennellate decise sui manifesti elettoriali, sembravano dire: io resto. Io resisto, e il Giappone ha risposto presente.
IL CROLLO DELL’OPPOSIZIONE
Il tracollo dell’Alleanza riformista centrista, passata da 167 a 49 seggi, non è solo una sconfitta, ma un vero e proprio annientamento.
Yoshihiko Noda e Tetsuo Saito, co-leader, parlano di dimissioni, ma il problema non è la leadership, bensì la stessa tenuta del progetto.
Fondere democratici costituzionali e Komeito sembrava una mossa geniale, perché metteva insieme il centro, attirava i moderati delusi e allargava la base, ma si è rivelato un abbraccio mortale, perché l’elettorato giapponese, che ha nella stabilità e nella prevedibilità due dei suoi valori cardini, non perdona le ibridazioni troppo ardite.
Komeito, con la sua anima buddista parlava un linguaggio, i democratici costituzionali un altro, perciò hanno confuso e spaesato gli elettori.
I CANI DA GUARDIA DELLA NUOVA DESTRA: SANSEITO E TEAM MIRAI
Quindici seggi per Sanseito. Undici per Team Mirai.
Sono numeri piccoli, nella grande aritmetica parlamentare, ma raccontano una storia enorme. Sanseito parla alla pancia, dicendo che gli immigrati sono troppi, parla di Giappone ai giapponesi, del fatto che la cultura va difesa con le unghie. È il linguaggio brutale dei populismi europei, tradotto in caratteri nipponici. E sembra funzionare.
Il partito Team Mirai è il partito della digitalizzazione totale, della società senza carta, dell’intelligenza artificiale al servizio dell’efficienza. E anch’esso sembra risultare affascinante.
Due facce della stessa medaglia, la quale unisce la ricerca di risposte semplici a problemi complessi.
La destra giapponese è come un giardino zen, dunque, apparentemente armoniosa, tuttavia, composta da elementi in competizione per la loro sopravvivenza. Basta poco perché l’equilibrio si rompa.
L’ABBRACCIO DI TRUMP: LA NUOVA ALLEANZA
Su Truth, le parole di Donald Trump ha scritto: “Pace attraverso la forza”. “Programma conservatore”. “Meraviglioso popolo giapponese”.
Somiglia a una dichiarazione di appartenenza agli stessi valori.
Takaichi, che nei confronti di Pechino ha già usato termini che i suoi predecessori si limitavano solo a suggerire tra le righe, riceve da Washington una legittimazione sovranazionale che rende il futuro fosco.
Perché la Cina non è, per il Giappone, solo un vicino ingombrante, ma significa modernizzazione contro tradizione, collettivismo contro gerarchia, potenza continentale contro potenza marittima.
Quando Takaichi allude a un intervento militare in caso di attacco a Taiwan, dice ai giapponesi che la paura è finita, perché adesso è il Giappone a far paura. È un messaggio potentissimo, ma è anche, oggettivamente, un azzardo, perché Taiwan non è solo una linea rossa per Pechino, ma il punto in cui il Giappone, se mai dovesse intervenire, si giocherebbe la propria esistenza nazionale in pochissimi giorni.
E, dovesse mettersi male, in quel caso nessuna super-maggioranza, nessuna alleanza con Trump, nessuna nave da guerra americana nel Pacifico, potrà mai garantire un esito differente.
IL DEBITO E LO YEN, LA PROMESSA POPULISTA
Veniamo ora alla parte che gli analisti finanziari chiamano, con eufemismo “sostenibilità fiscale”, quella che sembra più una bomba a orologeria che Takaichi ha ereditato e che, con la sua politica, rischia di innescare.
Il debito pubblico giapponese supera il 200% del PIL. È un mostro nutrito per decenni da tassi zero e dalla pazienza dei risparmiatori nipponici, un mostro che se n’è stato buono, ma ora si sta svegliando. I rendimenti dei bond a lungo termine hanno toccato livelli che non si vedevano da quando il cellulare non esisteva, e lo yen perde valore come una nave che imbarca acqua.
La premier, nel suo programma elettorale, promette di sospendere l’aliquota IVA sugli alimentari. Otto punti percentuali di minor gettito, in un paese che invecchia, che consuma più pensioni che produzione, che importa energia e cibo a prezzi sempre più alti.
Più che economia, sembra populismo fiscale. Ma il populismo fiscale, nella storia, ha sempre avuto due esiti: austerità dolorosa o default.
Takaichi lo sa. I suoi consulenti economici, persone serie, glielo ripetono ogni giorno, ma la macchina del consenso, una volta avviata, è difficile da fermare, perché ha promesso.
E, visto che ha vinto, ora deve mantenere la parola data, perciò il Giappone trattiene il respiro.
L’ARTICOLO 9 E LA FINE DELL’INNOCENZA COSTITUZIONALE
Ma è sulla difesa, naturalmente, che la maggioranza dei due terzi rivela il suo vero significato.
L’articolo 9 della Costituzione giapponese, quello che “per sempre” rinuncia alla guerra e al mantenimento di forze belliche, è da settant’anni un capolavoro di ambiguità creativa, perché è stato interpretato, aggirato, svuotato, ma mai formalmente modificato.
Takaichi, adesso, ha i numeri per indire un referendum, anche se non sarà facile. L’opinione pubblica giapponese, pur sempre più ansiosa per le minacce regionali, conserva un attaccamento quasi viscerale a quell’articolo, che non è solo legge, ma fa parte dell’identità del Giappone, è la promessa che il Paese, dopo Hiroshima, dopo Nagasaki, dopo la resa, ha fatto a se stesso e al mondo.
Tuttavia, Takaichi, come Abe prima di lei, considera quella promessa una palla al piede da cui liberarsi.
Il referendum non è ancora convocato, anche se l’ombra della consultazione si allunga già sul dibattito pubblico, insieme a tante domande sul pacifismo del Paese o sulla semplice inerzia, sulla mancanza del coraggio necessario per ammettere di non esserlo più.
IL GIAPPONE E IL NUOVO CONSERVATORISMO ASIATICO
Infine, uno sguardo al contesto.
Le elezioni in Thailandia, l’avanzata dei partiti di destra, la crescente domanda di “leadership forti” che attraversa il continente, dimostrano che non è solo il Giappone, ma si tratta di un’onda che monta su stagnazione economica, paure identitarie, frustrazione verso élite percepite come distanti dai cittadini.
Takaichi non è la causa di quest’onda, ma sa cavalcarla con abilità, anche se cavalcare un’onda significa non poterla fermare, non poterla guidare, ma vuol dire essere costretti ad andare dove l’onda ti porta, non dove vorresti andare.
E l’onda, oggi, spinge verso il riarmo.
Il Giappone, nella sua storia moderna, ha sempre avuto una straordinaria capacità di adattarsi agli tsunami senza perdere la propria essenza, ma questa volta, lo tsunami è interno, è arrivato dalle urne.
LA NOTTE DOPO LA NEVE
La notte dell’8 febbraio, i flash dei fotografi, gli applausi, i volti tesi dei dirigenti LDP, che ancora faticavano a credere all’entità del trionfo della Premier, che sorrideva per la vittoria, tutto raccontava di un cambio di prospettive, di una nuova era all’orizzonte.
Takaichi ha una super-maggioranza alla Camera, ma anche un Senato ostile. Ha un’economia che barcolla, un debito che pesa, un vicino che osserva ogni sua mossa e, soprattutto, ha la responsabilità di aver convinto un popolo intero a fidarsi di lei.
Questa volta, Takaichi non potrà fare solo promesse, perché i giapponesi ora si aspettano fatti.
E quei fatti potrebbero sconvolgere il mondo, perché se l’economia del Giappone implode, l’onda d’urto non risparmierà nessuno.